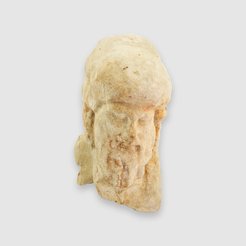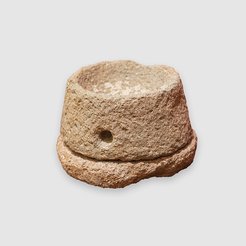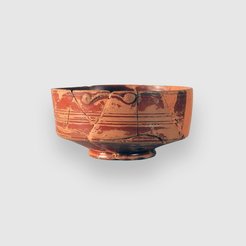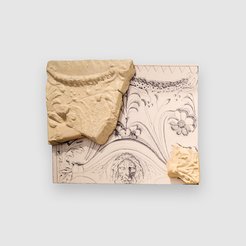Al centro della sala troviamo la groma, lo strumento grazie al quale i Romani tracciavano rette perpendicolari sul terreno per creare gli assi delle centuriazioni o per tracciare il percorso delle strade e degli acquedotti.
La groma è costituita da un bastone in legno la cui altezza si adattava a quella di chi doveva utilizzarla. L’estremità inferiore termina con una punta in metallo che veniva piantata nel terreno, mentre la parte superiore è costituita da un braccio rotante detto “rostro”. A questo sono agganciate due aste in legno rivestite di ferro e poste a croce. Dalle estremità della croce pendono due coppie di fili a piombo, con contrappesi a forma di cono.
La proiezione a terra dei quattro fili determinava le coordinate di orientamento, grazie alle quali venivano tracciate esatte linee divisorie. Guardando lungo ciascuno dei bracci, era possibile piantare dei paletti nel terreno a distanze regolari e, in questo modo, la terra veniva divisa in forme regolari (quadrati o rettangoli) chiamate “centurie”. Questo era possibile grazie alla presenza dell’agrimensore, figura esperta nella misurazione dei terreni e nella loro divisione.
La groma era usata anche su lunghe distanze, superando anche gli ostacoli naturali, come i fiumi, le colline e i boschi.
Questo strumento non è descritto da nessuno degli autori antichi: è stato possibile capire com’era fatto e come funzionava solo grazie al rinvenimento degli elementi che lo costituivano, avvenuto a Pompei nel 1912, nella bottega di Verus, un fabbro o forse un agrimensore. Le parti di una groma sono rappresentate anche nel monumento funerario dell’agrimensore L. Aebutius Faustus, un liberto vissuto nel I secolo d.C. a Ivrea, e sulla stele funeraria di Popidius Nicostratus, un abitante di Pompei dell’inizio del I secolo d.C., dove sono rappresentati anche i paletti piantati nel terreno.